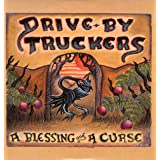Volentieri
ospito questo contributo dell’amico e collega Marco Denti tratto dal recente
suo libro, Storie Sterrate, edito da Jimenez, nel quale l’autore si
sbizzarrisce in modo originale ed approfondito a scovare collegamenti tra rock
e letteratura indagando nei musicisti che sono scrittori e negli scrittori che
sono musicisti. Cinquanta quadretti in cui musica e parole si abbracciano, si
sovrappongono , si completano, si confondono scegliendo una strada già
tracciata ed una storia sterrata. Chi ha narrato la propria autobiografia e
insieme tutta un’era, chi, scrivendo il proprio memoir, ha smantellato
un’intera carriera, chi ha varcato il confine tra memoir e romanzo, chi avrebbe
potuto scrivere un romanzo ed invece non l’ha mai fatto ma nelle sue canzoni ci
sono più storie che in un’intera bibliografia, chi l’ha fatto senza motivo e
chi per andare indietro nel tempo, o per andare avanti. Da Laurie Anderson a
Leonard Cohen, da Steve Earle a Suzanne Vega, da Morrisey a Elvis Costello, da
Elliott Murphy a Graham Parker, da Nick Cave a Lou Reed, da Warren Zevon a
Richard Hell, da Frank Zappa a Natalie Merchant, da Jim Carroll a Neil Young,
da Rickie Lee Jones a Lucinda Williams, da Willy Vlautin a Bruce Springseen. Il
rock è l’attimo, la letteratura ha bisogno di più tempo, cinquanta esempi di
strambo corteggiamento reciproco.
Volentieri
ospito questo contributo dell’amico e collega Marco Denti tratto dal recente
suo libro, Storie Sterrate, edito da Jimenez, nel quale l’autore si
sbizzarrisce in modo originale ed approfondito a scovare collegamenti tra rock
e letteratura indagando nei musicisti che sono scrittori e negli scrittori che
sono musicisti. Cinquanta quadretti in cui musica e parole si abbracciano, si
sovrappongono , si completano, si confondono scegliendo una strada già
tracciata ed una storia sterrata. Chi ha narrato la propria autobiografia e
insieme tutta un’era, chi, scrivendo il proprio memoir, ha smantellato
un’intera carriera, chi ha varcato il confine tra memoir e romanzo, chi avrebbe
potuto scrivere un romanzo ed invece non l’ha mai fatto ma nelle sue canzoni ci
sono più storie che in un’intera bibliografia, chi l’ha fatto senza motivo e
chi per andare indietro nel tempo, o per andare avanti. Da Laurie Anderson a
Leonard Cohen, da Steve Earle a Suzanne Vega, da Morrisey a Elvis Costello, da
Elliott Murphy a Graham Parker, da Nick Cave a Lou Reed, da Warren Zevon a
Richard Hell, da Frank Zappa a Natalie Merchant, da Jim Carroll a Neil Young,
da Rickie Lee Jones a Lucinda Williams, da Willy Vlautin a Bruce Springseen. Il
rock è l’attimo, la letteratura ha bisogno di più tempo, cinquanta esempi di
strambo corteggiamento reciproco.Lo stato delle cose: Bruce
Springsteen e il declino dell’impero americano
Non c’è stato nessuno più
prigioniero del rock’n’roll di Bruce Springsteen, perché alla base del
rock’n’roll c’è l’idea di una sfida, di una fuga, più di ogni altra cosa, di
una promessa, per cui ha dato tutto. Una prova celebrata nelle continue
metafore automobilistiche delle “macchine da suicidio”, da Thunder Road a
Racing in the Street fino alla definitiva sublimazione di The Promise.
Ma non è solo la strada: è correre nelle alleanze dell’amicizia, con l’idea di
muoversi insieme, la voglia sfrenata di attraversare lo spazio e il tempo come
mezzo per ritrovare, anche solo a livello epidermico, una via di scampo dalla
realtà e nello stesso tempo un mezzo per sentirsene parte. Non erano
competizioni semplici. Le gare erano affronti ai motori, agli altri
concorrenti, ai trucchi più o meno leali, alle città. Erano prove di coraggio:
la paura di non arrivare o di perdere non era contemplata. La messa a punto
comprendeva anche la misura delle speranze, il chiarire dei sogni e delle
illusioni. Ogni notte, ogni volta. Springsteen ha avuto un coraggio immane, e
mai abbastanza riconosciuto, nel rincorrere quel miraggio. È la terra promessa
senza la terra, è la sfida senza la gara, è esplodere senza scoppiare.

Negli anni il racconto di Springsteen è stato molto,
molto dettagliato, e si è sviluppato coltivando un’ossessione che ha trovato la
collocazione definitiva e insuperata nello psicodramma dei suoi concerti, ma
che restava pur sempre una promessa e in quanto tale irraggiungibile. Bruce
Springsteen ha spinto al massimo nella direzione sognante del rock’n’roll e si
è consumato, nel senso vero e proprio della parola, perché nessuno si è speso
più di lui per il proprio pubblico con un apice, volendolo trovare, in No Nukes,
nella condivisione di quel fantastico rituale con Jackson Browne e Tom Petty.
Ciò non di meno ha insistito nell’infondere energia su energia
nell’inseguimento di quel miraggio che resta un’attrazione magnetica, e per
dirla con il protagonista di The River, ha
continuato a scendere al fiume pur sapendo che il fiume ormai era asciutto. Il
senso del rock’n’roll è tutto nell’espressione di un desiderio che avrebbe
trovato un’ultima spiaggia nella malinconica destinazione di THE RIVER,
in particolare nelle ballate della seconda e conclusiva parte, che in qualche
modo conducevano a NEBRASKA e a BORN IN THE
U.S.A., e lì la corsa è finita.

C’è un vecchio film, Copland, dove il protagonista si mette
ad ascoltare Stolen Car, mentre tutto il suo mondo gli si sgretola at- torno
senza pietà. È quell’atmosfera crepuscolare, da Mansion on the Hill a My
Hometown che riporta inevitabilmente al
paesaggio del New Jersey, che si è sfaldato. La decadenza, anche architettonica
e urbanistica di quegli scorci di provincia, diventati una de- solata landa
suburbana, è andata in parallelo. In quel frangente, Springsteen si è rivelato
una voce potente, quando la terra promessa si è svelata in un intreccio di
raccordi autostradali e centri commerciali perché come scrive Richard Ford “il
mondo diventa più piccolo e più concentrato quanto più a lungo vi restiamo”, ed
è rimasta solo una città in rovine.
È stato un grande storyteller che ha costruito le
canzoni come piccoli film, quindi sempre con una prospettiva più vicina alle
immagini che alla parola. Ciò non toglie nulla all’altissima qualità del- la
sua narrativa, pur nelle mutazioni seguite nel corso degli anni,
dall’esuberanza colorita e beatnik degli esordi fino all’apoteosi di BORN TO RUN e
alle riflessioni più mature di DARKNESS ON
THE EDGE OF TOWN, THE RIVER e NEBRASKA, ma i paesaggi che stavano sullo
sfondo si sono incupiti e la terra della speranza e dei sogni è rimasta
un’illusione, o un bel tema per una canzone.
Nell’affrancarsi dalla desolazione di quei territori,
sono apparse trame più crude, ma anche più distanti. Le crime story di Murder Incorporated e Code of
Silence: nel corso degli anni,
fuorilegge e delinquenti si sono susseguiti in molte canzoni perché Bruce
Springsteen ha costruito delle miniature molto efficaci, rendendo persino
comprensibile la loro umanità. Nei primi versi di Atlantic City comprime
la vicenda di un personaggio che da solo è sufficiente a rappresentare il lato
oscuro e noir del songwriting di Springsteen, capace di creare un’intera
canzone a partire dal titolo di un giornale, guardandolo da una prospettiva
inedita e trasformandolo in una storia a parte. Non è da tutti. Ha saputo
trarre dalla fiction la forza ideale per raccontare la realtà americana del
ventesimo secolo ed è indiscutibile che si sia speso anche nell’approfondire
tematiche introspettive, come nell’intero TUNNEL
OF LOVE o con una rilevanza storica e
sociale come in THE GHOST OF TOM JOAD, American
Skin o Devils & Dust, o persino
fantasmagoriche come Outlaw Pete (compreso il libro a fumetti) o Hunter of Invisible Game, tutti tentativi di trovare altre soluzioni, ma
spesso dai risultati controversi. Il suo sogno restava sempre un altro.

In fondo tutti gli immaginari
sono circoscritti e definiti perché è proprio lì che indugia il lavoro
dell’artista. Il nocciolo della questione rispetto a Springsteen è che questa
continua invocazione della primordiale promessa emana una luce, un abbaglio che
gli altri non hanno, ma che poi è proprio come tutti gli altri, limitato lì.
Questa è la contraddizione, in fondo. Quel senso che emana dal rock’n’roll e
non ha corrispettivo nella letteratura perché quello che dice una storia è lì,
concluso per sempre (modifichi una storia e diventa un’altra storia), mentre
una canzone è una lusinga reiterata all’infinito. Nessuno (a parte Elvis) come
Springsteen ha interpretato il senso di quel sogno, l’ha cantato e descritto e
immaginato e recitato più e più volte, saltando da una parte all’altra del
palco. E ci ha convinto. Per una parte importante e ingombrante della sua
carriera e della sua vita Springsteen ha fatto di più: ha condiviso le sue
aspettative, il suo sogno, la sua fede e con ogni probabilità i motivi di una
sfida (implicita ed esplicita) che alimentava tutta la sua determinazione. Un
circolo chiuso, in definitiva, ma che ha creato un’attenzione straordinaria del
suo pubblico, a sua volta ricambiata con una generosità e un entusiasmo più
unici che rari.

Per quanto ampio, alla fine, l’immaginario di Bruce
Springsteen è circoscritto, è rimasto qualcosa di molto definito e concluso,
come se Springsteen avesse una visione completa e in qualche modo definitiva.
Springsteen ha ricostruito un paesaggio con una cura famelica del dettaglio.
Dalla sua scrittura, dal suo songwriting in apparenza sembrano evolversi interi
mondi, che in realtà implodono. Il rock’n’roll è evanescente ed effimero ed è
proprio in quei momenti che si vede con un’ottica diversa, quando si capisce
che la sua inutilità tiene insieme le nostre vite, ci salva dalla realtà. È una
prospettiva con tutti gli elementi dell’incognita e della speranza, è una
sfida, è un’illusione, che poi a bene guardare è quel miraggio tutto americano
della terra dei liberi e della casa dei coraggiosi.

I frequenti tentativi di espandere la realtà e la
fiction springsteeniane si sono rivelati dei viaggi in riserva e senza
destinazione. Se serve un esempio valga il caso di Tennessee Jones, con la
raccolta di racconti Liberami dal nulla: basato sulle suggestioni di NEBRASKA,
è forse lo sforzo più ambizioso dal punto di vista letterario, ma ancora peggio
è andata dal punto di vista cinematografico, do- ve gli sforzi per espandere la
forma delle canzoni di Springsteen si sono risolti di norma in piccole
caricature, più o meno ispirate. È mancato il senso stesso del rock’n’roll,
quel desiderio di arrivare da qualche parte (ma dove?) che alimentava il
battito e che una volta arenatosi nella placida sconfitta del “nowhere to run,
nowhere to go” di BORN IN THE U.S.A. si è poi trascinato in osservazioni più o meno
puntuali nel corso degli anni, compresi un capolavoro narrativo come THE GHOST OF TOM JOAD e uno sforzo coraggioso come THE
RISING. Ma la promessa, quella
promessa, è rimasta lì, sullo sfondo, come un’ombra, un avviso, una cambiale
non pagata. L’autobiografia è l’ammissione di quel limite, e non deve
sorprendere che il carattere meditabondo di ciò che è seguito, dalle repliche
di Broadway a WESTERN STARS non fa che confermare i contorni di quell’immaginario
che ha celebrato la promessa, ma non ha saputo ritrovarla. Non doveva nemmeno,
se è per quello.
Bisogna dire che a differenza di suoi emeriti
colleghi, vicini e lontani, Springsteen non ha mai indossato una maschera, non
ha mai interpretato un personaggio né sul palco né su disco, non si è negato
dietro Ziggy, non ha avuto rifugi come Idra, non si è nascosto nella o dalla
folla (anzi). Forse per raccontare le storie, e per conviverci, serve una
distanza di sicurezza che Springsteen non si è mai premurato di avere. Si è
messo alla pari, lui e il suo pubblico, nel realizzare un legame unico, ma ci
vuole un sacco di energia per tenere in piedi l’edificio, e lui ce l’ha messa
tutta. Una scelta spontanea, forse, e limitata, ma senza dubbio genuina, che ha
pagato in termini di energie e ha chiesto un “prezzo che devi pagare”. Deve
essere successo qualcosa del genere.
Parlando degli altri, in realtà Bruce Springsteen ha
parlato sempre di se stesso. Questo attrito, che ha generato una visione
singolare, si è inceppato nel momento in cui Bruce Springsteen ha parlato di se
stesso credendo di parlare anche per gli altri. Forse è solo una sensazione, ma
per spiegarla è utile l’opinione di Laurie Anderson, piuttosto insolita per il
popolo springsteeniano, ma arguta nel cogliere il senso della prospettiva: “Se
vedi Bruce Springsteen dal vivo, ti rendi conto dell’energia e della totalità
dell’evento, mentre se è inquadrato con l’idea di trasmettere una maggiore
intimità con le riprese ravvicinate, si perde tutta l’energia”. Il punto di
vista di Laurie Anderson, ripreso da una discussione con il critico d’arte
Germano Celant a proposito della qualità e della pro- spettiva delle immagini,
è curioso, ma rende l’idea.

Quando
ha deciso di confrontarsi con la scrittura è come se si fosse messo a scrivere
una storia che aveva raccontato un milione di volte e anche lui è caduto nella
trappola di infilarsi in quell’immaginario che era già tutto lì, che aveva già
espresso con le canzoni, con le chitarre, con il sassofono di Big Man, con la E
Street Band e con gli stadi che inneggiavano all’unisono il suo nome come se di
volta in volta volessero ritrovare un vecchio amico tornato da un lungo
viaggio. Spinto da un’esigenza chiaramente personale, Springsteen si è dedicato
al memoir e ne è uscito il resoconto (paradossale, sorprendente) di un uomo nel
confessionale che, per forza di cose, rispolverava storie già raccontate,
aggiungendoci particolari piuttosto intimi e dolorosi, ma incappando, come
tutti gli altri prima di lui, nelle medesime frontiere definite dal suo
immaginario. Il suo memoir si è rivelato timoroso e lacunoso, ma soprattutto
autosufficiente. Forse ha dato voce a così tanti personaggi o ha interpretato
così tanti personaggi da confondere se stesso. È vero che ha dato tutto, ma con
ogni probabilità c’è un prezzo da pagare, e non è relativo. Le aspettative ci
hanno tradito, ma avremmo dovuto ricordare quello che diceva ancora Richard
Ford, cioè che “i romanzi sono una specie di vento che tira i rimasugli della
vita quotidiana dalle strade polverose dove spendiamo i nostri giorni, li fa
avvitare nell’aria creando figure sempre nuove e ce li riporta addosso
lasciandoci lì con un mezzo sorriso sciocco, a chiederci cosa ci sia successo.
A chiederci perché ridiamo e perché piangiamo”. Anche la rilettura
dell’autobiografia nello scenario di Broadway non ha saputo aggiungere altro,
al di là dell’aspetto emotivo. Un anno di repliche è servito a capire che il
grande romanzo americano, quell’eterna balena bianca che fluttua
misteriosamente nel tempo e nei nostri desideri, non solo l’aveva già scritto,
ma l’aveva anche vissuto.
MARCO DENTI