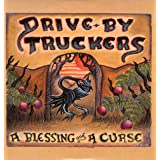Erroneamente
descritti come una band di Southern Rock, etichetta in qualche modo oggi
fuorviante, i Drive By Truckers si
sono rivelati una orgogliosa formazione del Sud senza peli sulla lingua, capaci
durante l’’amministrazione Trump di lanciare frecce avvelenate contro il
governo americano. Non si sono radicalizzati con l’arrivo del ridicolo e
pericoloso tycoon dai capelli arancioni, hanno cantato l’America lasciata ai
margini in tempi non sospetti quando, all’inizio degli anni duemila, con tre album
in sequenza definirono un amaro punto di vista del Sud odierno. Dopo il
burrascoso e giovanile avvio all’insegna di un punk sporco di radici, nel 2001 con
Southern
Rock Opera rivedevano con
disincanto ma inalterato amore l’epopea di quel genere e dei suoi protagonisti, e
nei tre anni a seguire con Decoration Day e The Dirty South raccontavano
attraverso un rock arruffato, sincero e disordinatamente coinvolgente, l’incubo
a cielo aperto di una terra trasfigurata da un artificioso progresso imposto
dalle corporation, dalla corruzione politica e da interessi incuranti della
vita delle persone. A metà strada tra orgoglio e disprezzo per un paese che da
sempre rivendica la propria diversità e le sue ossessioni puritane, Patterson Hood, Mike Cooley, entrambi nativi dell’Alabama, e compagni non si sono
fatti inghiottire dagli stereotipi sudisti, cantando piuttosto le dissonanze e le
desolazioni umane di una società stridente, contradditoria, sbriciolata. Un
paese senza ritorno che può sopravvivere solo cantando le proprie disfatte e le
proprie miserie. E cosi hanno fatto i Drive By Truckers parlando “dell’ascesa e caduta del Southern Rock, rispettandone
miti e leggende, ma anche dell’umanità inscindibile di quella regione, di gente
umiliata ed emarginata, spesso pronta a trasformare le proprie rivendicazioni
in una sorta di sciovinismo” (Fabio Cerbone, Levelland). Per poi affrontare nel sanguigno e
variegato The Dirty Sound un
universo di povertà, superstizione, incesti, catastrofi ambientali,
dissoluzioni famigliari, dipendenze di varia forma e natura. Con l’intatta
capacità, comunque, di usare il rock n’roll, e i suoi piccoli e grandi miti (Carl Perkins’ Cadillac, Danko/Manuel,Steve
McQueen,Ronnie and Neil, Cassie’s Brother) per un messaggio democratico in grado di
offrire un senso di appartenenza ad una memoria comune, piuttosto che un
alienato orgoglio regionale. Le canzoni dei Drive By Truckers sono zeppe di
riferimenti geografici, nomi di persone, inflessioni sudiste, caricature
locali, ricordi, frullati dentro un
sound che è spugna di una miriade di idiomi disparati, un intreccio di rock
n’roll, Delta blues, country-soul, rhythm and blues, interpretati con l’urgenza
di una scapigliata garage band.
Erroneamente
descritti come una band di Southern Rock, etichetta in qualche modo oggi
fuorviante, i Drive By Truckers si
sono rivelati una orgogliosa formazione del Sud senza peli sulla lingua, capaci
durante l’’amministrazione Trump di lanciare frecce avvelenate contro il
governo americano. Non si sono radicalizzati con l’arrivo del ridicolo e
pericoloso tycoon dai capelli arancioni, hanno cantato l’America lasciata ai
margini in tempi non sospetti quando, all’inizio degli anni duemila, con tre album
in sequenza definirono un amaro punto di vista del Sud odierno. Dopo il
burrascoso e giovanile avvio all’insegna di un punk sporco di radici, nel 2001 con
Southern
Rock Opera rivedevano con
disincanto ma inalterato amore l’epopea di quel genere e dei suoi protagonisti, e
nei tre anni a seguire con Decoration Day e The Dirty South raccontavano
attraverso un rock arruffato, sincero e disordinatamente coinvolgente, l’incubo
a cielo aperto di una terra trasfigurata da un artificioso progresso imposto
dalle corporation, dalla corruzione politica e da interessi incuranti della
vita delle persone. A metà strada tra orgoglio e disprezzo per un paese che da
sempre rivendica la propria diversità e le sue ossessioni puritane, Patterson Hood, Mike Cooley, entrambi nativi dell’Alabama, e compagni non si sono
fatti inghiottire dagli stereotipi sudisti, cantando piuttosto le dissonanze e le
desolazioni umane di una società stridente, contradditoria, sbriciolata. Un
paese senza ritorno che può sopravvivere solo cantando le proprie disfatte e le
proprie miserie. E cosi hanno fatto i Drive By Truckers parlando “dell’ascesa e caduta del Southern Rock, rispettandone
miti e leggende, ma anche dell’umanità inscindibile di quella regione, di gente
umiliata ed emarginata, spesso pronta a trasformare le proprie rivendicazioni
in una sorta di sciovinismo” (Fabio Cerbone, Levelland). Per poi affrontare nel sanguigno e
variegato The Dirty Sound un
universo di povertà, superstizione, incesti, catastrofi ambientali,
dissoluzioni famigliari, dipendenze di varia forma e natura. Con l’intatta
capacità, comunque, di usare il rock n’roll, e i suoi piccoli e grandi miti (Carl Perkins’ Cadillac, Danko/Manuel,Steve
McQueen,Ronnie and Neil, Cassie’s Brother) per un messaggio democratico in grado di
offrire un senso di appartenenza ad una memoria comune, piuttosto che un
alienato orgoglio regionale. Le canzoni dei Drive By Truckers sono zeppe di
riferimenti geografici, nomi di persone, inflessioni sudiste, caricature
locali, ricordi, frullati dentro un
sound che è spugna di una miriade di idiomi disparati, un intreccio di rock
n’roll, Delta blues, country-soul, rhythm and blues, interpretati con l’urgenza
di una scapigliata garage band.Nella
sterminata discografia dei DBT (13 album in studio, 6 live più o meno
ufficiali, due collection ed una pletora di singoli ed EP) chiunque può ritrovare
un pezzetto della loro visione, dall’innocente euforia punk di Gangstabilly
e Pizza Deliverance alla lucida trilogia “sudista”
menzionata sopra, dalla grandiosità di English Oceans alle allucinazioni di Brighter Than Creation’s Dark , dalla
sobrietà rock di A Blessing and A Curse al
southern country-soul (Patterson Hood è figlio di David Hood, storico bassista
di Muscle Shoals) di The Big To-Do e Go-Go Boots, per chiudere con gli
episodi arrabbiati e politici di American
Band, The Unraveling e The
New Ok , ultimi capitoli di una saga che ha ribaltato il concetto
stesso di Southern rock.
L’intero
cammino discografico avrebbe bisogno di un libro intero, qui mi limito a
segnalare tre album live registrati in
momenti diversi, in grado però di offrire un angolato spaccato della loro evoluzione
artistica. Beninteso, non c’è pellicola migliore per fotografare una band in action se non osservarla in
concerto, considerato poi che nell’ambito live le formazioni del Sud non sono
seconde a nessuno. Se Alabama Ass Whuppin'
registrato
nel 1999 in diversi locali di Athens, città dove sono cresciuti come collettivo,
è
il furioso attestato della loro giovanile attitudine punk mischiata con i
bollori di una disordinata vita sulla strada,
bisogna aspettare il 2006 per avere qualcosa di più solido e maturo. In realtà la
testimonianza uscirà anni più tardi in occasione di un record store day nel
formato di un triplo vinile, assemblato come un bootleg degli anni settanta,
salvo l’aggiunta all’interno di un poster disegnato dal loro grafico di
fiducia, Wes Freed, (poco meno di un
membro della band) in quello stile
gotico-sudista che ha identificato la loro
iconografia .
In quell’anno
i Drive By Truckers fecero più di 200 concerti di promozione all’album A
Blessing and A Curse. La band si
era fatta notare per delle esibizioni viscerali e arrembanti, conquistandosi
seguito e popolarità ma problemi personali e finanziari si addensavano sopra la
loro testa e la “famiglia” cominciava a
mostrare segni di stanchezza. Il matrimonio tra il chitarrista e cantante, Jason Isbell, unitosi alla band nel
2001, e la rispettiva moglie, la bassista Shonna
Tucker entrata nel 2004, cominciava
a scricchiolare e di lì a poco avrebbero divorziato, qualcun altro aveva avuto
figli e stare cosi a lungo on the road diventava
difficoltoso. Il mantenimento dell’equilibrio fu opera delicata e non fu certo di
aiuto l’ingente quantità di birra e whiskey che innaffiava le giornate della
band. Inoltre, il nuovo album non aveva ricevuto la stessa accoglienza dei
precedenti, i fans si aspettavano un altro The Dirty South e avvertivano i travagli che accompagnarono la
sua realizzazione. Con le finanze ridotte al lumicino, i DBT accettarono in estate
un tour nazionale come supporter dei Black Crowes ,ma dato che le band in cartello
ogni sera erano tre, si trovarono costretti ad un set di 35 minuti nel tardo
pomeriggio, quando invece i loro show mediamente duravano tre ore. Arrivarono a
Richmond in Virginia a luglio, stanchi e frustrati. L’anno, in quella città,
non era cominciato nel migliore dei modi. Il giorno di capodanno del 2006 un
crimine orrendo aveva impressionato l’intera nazione. Kathryn e Bryan Harvey assieme
ai loro due figli di 9 e 4 anni, e tre membri della famiglia Baskerville-Tucker
erano stati brutalmente massacrati nelle loro case di Richmond, e le immagini
di quell’orrore avevano fatto il giro delle TV nazionali destando shock e
dolore. I DBT avevano appreso del fattaccio nel mentre di una telefonata con l’amico
Wes Freed, il quale conosceva molto bene la famiglia Harvey. Un altro amico di
infanzia di Patterson Hood ovvero Jay
Leavitt gestiva a Richmond l’emporio di dischi Plan 9 Records, ubicato
proprio di fronte al negozio di giocattoli World of Myrth di proprietà di una
delle vittime, Kathryn Harvey. Erano buoni amici ed amavano entrambi i Drive By
Truckers. Gli stessi Harvey spesso frequentavano i loro concerti, e come
risposta, Patterson Hood quando il tempo glielo permetteva, si spingeva fino ad
Huntsville per vedere in scena Bryan, cantante e chitarrista degli House of Freaks. Tutti questi legami,
bruscamente spezzati dal brutale eccidio per rapina (i due autori Ray Dundridge e Ricky Gray sono stati
condannati all’ergastolo e alla pena capitale) spinsero i DBT a rendersi disponibili per un benefit
concert indetto dalla Harvey Foundation e organizzato da Jay Leavitt proprio nei
locali del suo Plan 9 Records. Unico compenso una cassa di birra e due
bottiglie di whiskey. Duecento persone accorsero a quell’evento, svoltosi nel
25esimo anniversario di apertura del negozio. Sciolto ed informale ma
estremamente emozionante, Plan 9 Records July 13, 2006 , questo
il titolo del triplo vinile, è considerata dagli stessi DBT una delle loro
migliori performance di quell’era, quando la band contava sui tre chitarristi e
cantanti Hood, Cooley ed Isbell, sulla bassista Shonna Tucker, sul batterista Brad Morgan, e sul virtuoso di lap
steel John Neff, uno attorno al
gruppo fin dagli esordi. Solo qualche
mese dopo questa line-up sarebbe cambiata, qualcuno andandosene per la propria
strada, pur rimanendo buoni amici. Quel mitico show del 13 luglio 2006 sancisce
la fine di una fase, documentato da sei facciate di disco a dir poco devastanti.
Un live che comincia quasi in sordina per poi esplodere in una deflagrazione
elettrica talmente coinvolgente che fa pensare all’idiozia di quanti sentenziano
che l’idea romantica e pura del rock n’roll è ormai roba da idealisti, e scontato
è accettare l’uso di questo per vendere auto, lingerie, jeans e quant’altro. Forse
sarà così ma non hanno fatto i conti con autentici outsiders come i Drive By
Truckers, la cui sincerità depone per una visione non compromessa della musica.
Il materiale di A Blessed and A Curse è
una, ma non la sola, delle anime del concerto visto che in quei giorni i DBT lo
stavano promuovendo. Feb 14, Aftermath
USA, Gravity’s Gone, Easy On Yourself, Wednesday fanno da riscaldamento prima che la band si
scateni in una performance vibrante, trascinante e sudata che si sviluppa
attorno al talkin’ narrativo di Hood e a quelle fiammate che rendono ribollenti
le ballate, intrise sia di disperazione che di romanticismo. Per contrasto il cantato monocorde di Cooley allenta
la tensione scalando le marce ma mantenendo salda la direzione rock , in mezzo
la voce malinconica di Jason Isbell, accompagnata dai languori della pedal
steel di Johnny Neff, evoca paesaggi country. Come se i Black Crowes si
unissero ai Lucero nelle desolate pianure desertiche dei Richmond Fontaine. La
tempesta chitarristica trae beneficio dal suono della lap-steel, Nine Bullets emana sapori di country-rock anni ’70, Decoration
Day sembra scritta dopo decine di
ascolti consecutivi di Simple Man dei Lynyrd
Skynyrd, i quali riappaiono nell’ applauditissimo faccia a faccia di Ronnie and Neil, dove si sentono sia
l’uno che l’altro. Brillano i pezzi
forti del loro repertorio più antico : la chiacchierata e rutilante 18 Wheels Of Love, il folk stravolto di The Day John Henry Died, la dolce Marry Me, una scorticata Zip City che pare rubata ai Crazy
Horse, l’ imprevedibile Moonlight
Mile di Sticky Fingers e poco “coperta” dagli stessi Stones, la
commovente A World of Hurt e quella Let
There Be Rock in cui Hood racconta
di essere nato troppo tardi per vedere gli storici Lynyrd Skynyrd ma di essersi
consolato con Molly Hatchet e AC/DC. Plan 9 Records July 13, 2006 è un live formidabile che ritrae una
band in completa ascesa, un documento imprescindibile per gli amanti del rock
n’roll.
Ma è Brighter Than Creation’s Dark ad offrire ai DBT la possibilità di
mostrare una facciata intimista. I suoni acustici di Perfect
Timing e Heathens inducono ad atmosfere country, Mike Cooley si concede la splendida A Ghost To Most , accompagnato nei paesaggi dell’Ovest dalla
evocativa lap steel di Neff, gli risponde pressante Hood in The Righteous Path con le elettriche e
la lap steel che si impastano in un sentiero fatto di promesse e cadute. Shonna
Tucker firma e canta la dolente I’m Sorry
Huston prima che la rugginosa 3 Dimes
Down apra la seconda parte dello show, la più corposa. Meno dirompente e
lungo di Plan 9 Records, Live From Austin attesta un momento di transizione nella loro
storia, prima della definitiva consacrazione.
MAURO ZAMBELLINI